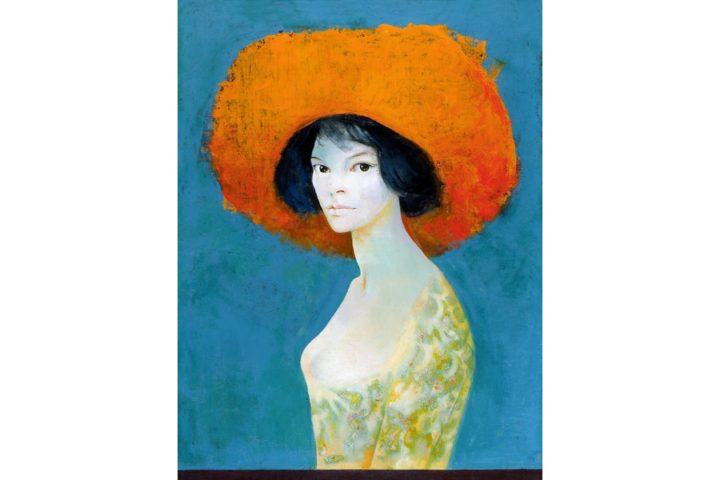Classe 1960, Maurizio Cattelan si forma senza frequentare nessuna accademia d’arte, bensì da autodidatta. Intraprende la sua carriera artistica a partire dagli anni Ottanta nella città di Forlì, per poi spostarsi a Milano dove acquisisce sempre più successo. Oggi è artista, giornalista, gallerista, curatore.
Sei famoso per essere un artista con una formazione da autodidatta. Credi che sia questo l’ingrediente segreto del tuo genio creativo? Pensi che studiando la tua espressività sarebbe stata in qualche modo indottrinata, modificata?
Non credo esistano ingredienti segreti per essere creativi, ma neanche formule preconfezionate che si possono imparare a scuola, o in accademia. È come un gioco da tavolo accompagnato da un manuale di regole complicatissime: tutti sappiamo che è molto più facile capirci qualcosa iniziando a giocare, piuttosto che perdere tutta la serata a imparare le istruzioni a memoria. Imparare come si fanno e non si fanno le cose, apprendere le regole del gioco, può essere utile solo nel caso in cui tu abbia interiorizzato anche la libertà di sovvertirle.
Il successo inizia quando, alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna, esponi “Stadium 1991”. Cosa rappresenta oggi per te quell’opera?
È stata un’opera in più atti. In quel periodo non mi ero ancora trasferito a Milano, stavo a Forlì e gravitavo intorno a Bologna. Avere una squadra di calcio è, oggi come allora, uno status symbol, non solo in Italia. Quelli erano gli anni di Gullit e di Berlusconi, ma anche delle navi di migranti che cercavano un futuro migliore in Italia, e della Lega Nord. Tutto questo sfociò prima in una squadra di calcio composta da giocatori migranti, da quello che oggi chiameremmo Global South. La squadra si chiamava A.C. Forniture Sud, sponsorizzata da una fantomatica ditta Rauss. Andai a promuovere la squadra con uno stand abusivo ad ArteFiera quell’anno: ogni mattina sistemavo il tavolo, la sedia e, per sembrare più professionale, un telefono, e mostravo il pieghevole pop-up con la foto della squadra e lo stemma. Credo che Barilli mi abbia visto in quell’occasione e abbia deciso di invitarmi alla mostra Anni Novanta alla GAM di Bologna. Avrei voluto far giocare la squadra, ma nel museo non c’era lo spazio per improvvisare un campo da calcio, così ho pensato di declinare la stessa squadra su un biliardino fatto ad hoc, per undici giocatori. Incredibilmente ho trovato un produttore, Garlando, disposto a fare una modifica al loro prodotto, a patto di fare prima un test in azienda coi suoi dipendenti. È stata credo la cosa più vicina a una performance che io abbia mai fatto.

Qual è l’opera di cui vai più fiero, che più parla di te come artista?
Non ho mai dubbi su come rispondere a questa domanda, è Torno subito. La sto valutando anche come epitaffio, anche se penso che quella davvero insuperabile sia Non escludo il ritorno.
Artista, giornalista, gallerista, curatore…in quale ruolo senti di esprimerti completamente?
Ci sono dei giorni in cui ti alzi e senti che stai bene con te stesso. In quei giorni puoi vestire tutti gli abiti che vuoi, ti senti invincibile in qualsiasi ruolo, e ti sembra che tutto funzioni nel modo migliore. Ce ne sono altri, più o meno storti, in cui nessun abito veste bene. Quasi non vorresti avere un guardaroba, per stare nella metafora. Non credo che sia tanto importante il ruolo in fin dei conti, ma cosa dici e come quando ti esprimi.
Sei famoso per essere un artista irriverente. Questo tuo lato ti ha mai fatto sentire fuori dal coro nel panorama artistico?
No, anzi. È stato quello che mi ha permesso di entrare nell’arena. Per me irriverenza e timidezza sono state due facce della stessa medaglia: una è lo scudo dell’altra. L’irriverenza è stato uno stratagemma, il lasciapassare per riuscire a farmi accettare dal panorama artistico, per dirla con le tue parole. Il problema è venuto dopo, quando tutti hanno iniziato ad aspettarsi quel personaggio e io ho lasciato che me lo cucissero addosso. C’è stato un momento in cui forse avrei dovuto oppormi, combattere quell’etichetta appiccicosa, ma quando ne sono stato consapevole era troppo tardi. Penso che, col tempo, ogni lavoro avrà modo di ridefinirsi, di compiersi lontano da me. In quel momento ogni opera sarà compresa per quello che era davvero, lontano dalla mia ombra.
Ti sei mai sentito minacciato dalle critiche?
No. Penso che qualsiasi critica autorevole sia utile, e non possa essere mai minacciosa. Se sei sicuro di quello che fai, e se il contenuto che produci è vero, rilevante, urgente anche, non c’è critica che possa minacciarti. Non parlo di presunzione. Parto sempre dal presupposto che sia impossibile accontentare tutti, e non credo sia nemmeno desiderabile quando si tratta di arte. La coralità mi aiuta a capire meglio quello che ho fatto, mi fa comprendere sfumature che io stesso non avevo così chiare fino al momento prima. È un momento di crescita, mai di paura.

Breath Ghosts Blind è una mostra che vuole riflettere sui paradossi della società. Quali sono i messaggi che vuoi trasmettere al pubblico?
Se fossi un’azienda, o un’ideologia, di sicuro trasmetterei messaggi chiari, inequivocabili. Ma l’arte per natura è ambigua: non promuove un prodotto, e non fa propaganda. È un mezzo per uscire da una visione univoca: ogni cosa può essere detta almeno in due modi, quello che si intende davvero, e quello, molto più interessante, e a volte comico, che ci ricorda come il mondo sia molto più complicato e contraddittorio.
La situazione pandemica degli ultimi due anni ha inciso sulla tua creatività?
Ha cambiato il mondo, e tutti noi. Per quanto riguarda il mio lavoro, ha aperto delle opportunità e ne ha chiuse delle altre. Ha spinto sull’acceleratore della smaterializzazione, su cui le nostre società stavano già appoggiando il piede da qualche tempo. Ho trovato interessante la sincronicità con cui questo è avvenuto, come se non fosse successo per una serie di eventi casuali, come invece è stato.
Come sei riuscito a gestire i tuoi progetti in quel periodo?
Esattamente come prima, in realtà. Ho semplicemente cambiato piattaforma, passando da skype a zoom. Per il resto le mie giornate non sono cambiate molto: ho sempre lavorato a distanza, prima al telefono e poi dal computer. Però un’esperienza very 2020 l’ho fatta: per Toiletpaper magazine, con Pierpaolo Ferrari, abbiamo scattato per il numero di Vanity Fair i talent degli Oscar senza che né noi né loro potessimo muoverci da casa. Abbiamo fatto una lunga preparazione degli scatti e poi li abbiamo coordinati da online, con troupe sul posto che eseguivano quello che dicevamo dall’altro capo del mondo, come un’operazione chirurgica fatta con le macchine. Non posso dire che sia stato identico a come avremmo lavorato in studio, ma è stato un esperimento interessante e senza precedenti.

Dove ti vedi artisticamente in un futuro prossimo?
Nel buco nero in cui scienza e arte finalmente si incontreranno.
Un ringraziamento speciale a Maurizio Cattelan per la disponibilità, augurandogli il meglio per la sua vita e i suoi progetti futuri.